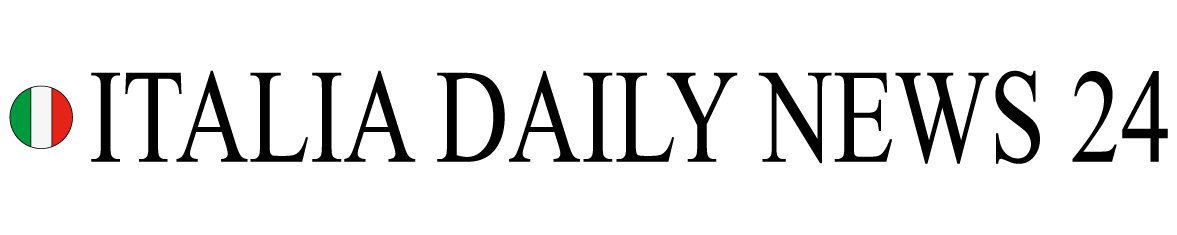Nel dibattito acceso sull’introduzione del salario minimo in Italia, si confrontano visioni opposte: da un lato la necessità di tutelare i lavoratori più deboli, dall’altro la tenuta economica delle imprese e l’equilibrio della contrattazione collettiva. L’Avvocato Marco Proietti, esperto di diritto del lavoro, giuslavorista e consulente presso il Ministero del lavoro, offre un’analisi tecnica e controcorrente delle ricadute reali che un salario minimo fissato per legge avrebbe sul tessuto produttivo italiano.
di Roberta Imbimbo

Avvocato, lei sostiene che il salario minimo legale non sia applicabile in Italia a causa dell’elevato cuneo fiscale e contributivo. Quali sarebbero, nel concreto, gli effetti di un salario minimo fissato a 9 euro l’ora sulle piccole e medie imprese italiane, in termini di sostenibilità economica e occupazione?
Il tessuto produttivo italiano si fonda su un equilibrio complesso, nel quale la contrattazione collettiva rappresenta l’architrave capace di bilanciare esigenze datoriali e tutele del lavoro. Introdurre un salario minimo legale uniforme significherebbe innestare un meccanismo rigido su un sistema già fragile, dove il cuneo fiscale e contributivo grava pesantemente su imprese e lavoratori. Una soglia di 9 euro l’ora, imposta per legge e applicata trasversalmente a tutti i settori, non terrebbe conto delle profonde differenze economiche e territoriali che caratterizzano il Paese. In molti comparti – dal commercio ai servizi alla persona, dall’artigianato alla ristorazione – i margini di sostenibilità sono talmente ridotti da rendere l’adeguamento immediato semplicemente impraticabile. Il rischio concreto sarebbe quello di spingere le micro e piccole imprese verso l’irregolarità, non per volontà di eludere le regole, ma per sopravvivenza economica. In assenza di interventi strutturali sul costo del lavoro, l’aumento imposto delle retribuzioni potrebbe tradursi in una drastica riduzione delle assunzioni regolari, un incremento dei contratti a termine o, nel peggiore dei casi, nella chiusura delle attività meno solide. In altre parole, l’intento di tutelare i lavoratori rischierebbe di produrre l’effetto opposto: comprimere l’occupazione e ampliare l’area del lavoro sommerso, con conseguenze negative per la competitività complessiva del sistema produttivo.
Lei ha sollevato la preoccupazione che il salario minimo legale possa “scavalcare i sindacati” e annullare il ruolo della contrattazione. In che modo questo potrebbe accadere e quali sarebbero le conseguenze per i lavoratori?
Una quota rilevante del contenzioso del lavoro in Italia riguarda le differenze retributive e l’applicazione dei contratti collettivi. Se una legge imponesse una soglia unica di 9 euro l’ora, le imprese avrebbero tutto l’interesse ad attenersi strettamente a quella cifra, evitando di applicare qualsiasi contratto collettivo. In pratica, una volta rispettato il minimo legale, il datore di lavoro potrebbe negoziare “uno a uno” con il dipendente, garantendo solo gli standard previsti dalla legge ma tagliando fuori i sindacati dal tavolo della contrattazione. Il sindacato perderebbe così il suo tema centrale di confronto — la retribuzione — riducendo la propria funzione a un ruolo puramente simbolico. La concertazione, vero cardine del modello italiano, verrebbe meno.
Se il salario minimo rischia di appiattire le retribuzioni, l’alternativa è rafforzare la contrattazione collettiva. Come si può garantire che i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) assicurino una retribuzione equa e scongiurino l’uso dei “contratti pirata”?
Esistono due strade complementari. La prima è il riferimento alle tabelle retributive dell’INPS, che fotografano i minimi salariali reali dei vari settori e consentono adeguamenti coerenti con il costo della vita. La seconda, e più strutturale, è una legge sulla rappresentanza sindacale che dia validità “erga omnes” ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni realmente rappresentative. Solo così si può evitare la proliferazione dei cosiddetti contratti pirata, stipulati da sigle minori per abbassare i costi del lavoro.
Lei propone una legge sulla rappresentanza come chiave per eliminare i contratti pirata e rafforzare le relazioni industriali. Quali dovrebbero esserne i pilastri per garantirne l’efficacia?
Servono due elementi: trasparenza e misurabilità. Occorre rendere pubblici i dati sulla consistenza numerica e sui bilanci delle sigle sindacali, così da stabilire chi rappresenta realmente i lavoratori. In questo modo si risolverebbe una questione rimasta sospesa dal 1949: la mancata attuazione dell’articolo 39 della Costituzione, commi 3 e 4, che prevedeva la registrazione dei sindacati e la validità generale dei contratti stipulati da quelli più rappresentativi. L’assenza di questa norma ha prodotto un effetto distorsivo: oltre mille contratti collettivi depositati al CNEL e un sistema ingestibile. Una legge sulla rappresentanza darebbe finalmente certezza e renderebbe più efficace anche la contrattazione di secondo livello.
In molti Paesi europei il salario minimo legale è una realtà consolidata. Perché in Italia sarebbe diverso?
In realtà, in Italia i minimi retributivi esistono già, ma sono fissati dai contratti collettivi e non da una legge. La differenza principale rispetto agli altri Paesi europei risiede nel cuneo fiscale e contributivo: in Italia, per ogni euro netto che percepisce il lavoratore, l’azienda ne paga quasi due.
Questo squilibrio rende impraticabile un salario minimo legale elevato senza prima intervenire su tasse e contributi. L’errore è credere che il problema sia la paga oraria; in realtà è il peso fiscale sul lavoro che penalizza tanto i dipendenti quanto le imprese. Senza un taglio deciso al cuneo fiscale, ogni salario minimo rischia di essere solo una misura simbolica, incapace di migliorare davvero la condizione dei lavoratori.