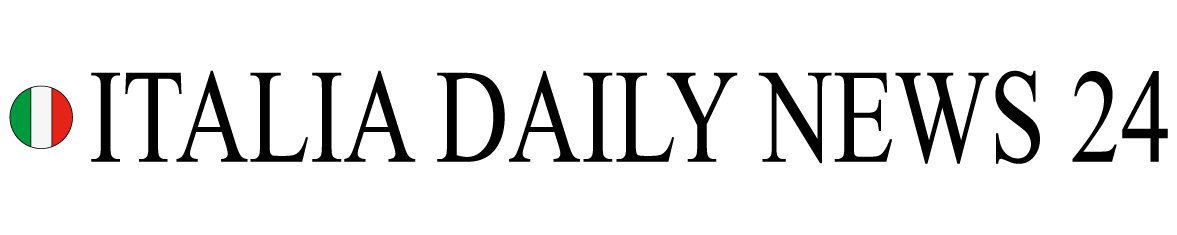Oggi un numero sempre crescente di giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, chiudendosi in casa, senza aver un contatto diretto con il mondo esterno, a volte nemmeno con i propri genitori. Cominciano così a scambiare il giorno con la notte, ad abbandonare gli studi, a trascurare le amicizie, finché scatta una vera e propria “sindrome da ritiro sociale”: il termine giapponese Hikikomori – che letteralmente significa “stare in disparte” – è usato in gergo per indicare quei giovani che vivono in casa prigionieri di se stessi, della propria ansia o depressione. Affrontiamo questo delicato argomento con Michele Miccoli, Avvocato Penalista, Professore Universitario ordinario di Diritto penale presso L’Università Internazionale degli Studi di Milano, Presidente nazionale dei Sociologi italiani Associati, autore di numerose pubblicazioni accademiche e di diversi libri tra i quali “Hikikomori. Il nuovo male del secolo” (pubblicato nel 2018 da Lupetti editore), nel quale l’autore porta in evidenza un fenomeno che purtroppo si sta dilagando a macchia d’olio e che, proprio per questo, implica un’attenta riflessione.
di Roberta Imbimbo
Prof. Miccoli, chi sono gli Hikikomori?
L’ hikikomori è un complesso disagio psichico giovanile caratterizzato da un rifiuto della vita sociale, scolastica o lavorativa per un periodo di tempo prolungato, di almeno 6 mesi, e conseguentemente, da una mancanza di relazioni intime ad eccezione di quelle con i parenti più stretti. Il fenomeno – che solo In Italia coinvolge ormai 120 mila ragazzi – sta assumendo dimensioni preoccupanti, anche a fronte delle risorse molto ridotte che il nostro Paese ha stanziato per la psichiatria in età evolutiva. L’autoisolamento è oggi la seconda causa di suicidio tra i giovani ed è la prima causa di atti autolesionistici, finalizzati a provocare danni al proprio corpo in modo volontario, non sempre necessariamente a scopo suicidario. Si tratta quindi di un problema molto serio che purtroppo, dopo il Covid, si è moltiplicato esponenzialmente: prima della pandemia, infatti, i ricoveri per autolesionismo rappresentavano circa il 25-30%dei casi, oggi il 65-70%. Gli ultimi dati forniti dalla Federazione Italiana Medici Pediatri parlano inoltre di un incremento di tentati sucidi negli ultimi due anni del 75%. Ogni giorno in Italia un adolescente cerca di togliersi la vita. E 150 mila ragazzi vivono isolati, senza alcuna interazione sociale con il resto del mondo. A fronte di queste cifre allarmanti le richieste di consulenze neuropsichiatriche, anche in urgenza, sono aumentate di 40 volte.
Come riconoscere un Hikikomori? Quali sintomi devono preoccupare un genitore?
Gli Hikikomori sperimentano l’esclusione sociale attraverso l’autoisolamento. La riluttanza a uscire di casa può essere dovuta a diverse cause tra cui: depressione clinica, fobia sociale o disturbi d’ansia. Anche la dipendenza dai social network è stata ampiamente associata alla sindrome, poiché i giovani Hikikomori finiscono per usarli come unico mezzo di comunicazione e di interazione. Gli adolescenti scelgono di ritirarsi drasticamente dalla vita reale, abbandonando il circuito naturale relazionale e dedicandosi esclusivamente al mondo virtuale. Un mondo creato artificialmente per evitare ancor di più il contatto umano, peggiorando in tal modo lo stato della patologia e dando un illusorio senso di avercela fatta ad essere usciti dalla paura della relazione sociale reale. Ma vi possono essere anche altre cause: bullismo, sopraffazione, alte aspettative da parte della famiglia. La scuola è il primo luogo che può aiutarci ad identificare i primi campanelli di allarme, in quanto è il luogo in cui il giovane può essere maggiormente esposto ad atti di bullismo e pressione sociale. Ma non solo. I giovani possono temere di deludere le alte aspettative della propria famiglia e di non essere in grado di gestire la pressione sociale e il confronto con il mondo esterno. Il senso di continuo fallimento per non avercela fatta a raggiungere gli standard desiderati può provocare la perdita di interesse per la vita, l’inversione del ritmo sonno-veglia, sentimenti intensi di ansia, depressione, panico che inducono il giovane ad abbandonare gli studi (nonostante nella maggior parte dei casi i rendimenti scolastici siano estremamente elevati), lo sport, le amicizie, ad isolarsi nella propria stanza che diventa in tal modo un rifugio sicuro dal mondo esterno.
Come trattare un caso di Hikikomori?
Trattandosi di una vera e propria dipendenza come tale va approfondita dal punto di vista terapeutico, cercando di cogliere tempestivamente i primi segnali di disagio, non sottovalutando le richieste di aiuto dei ragazzi in difficoltà, non vivendo questa patologia come una vergogna o un fallimento del proprio figlio ma promuovendo invece momenti di ascolto, di dialogo e incoraggiando le occasioni di relazioni soprattutto con i pari. Sebbene avere un figlio Hikikomori sia una sfida difficile per molti genitori, è opportuno rivolgersi ad uno specialista qualificato, in grado di condurre lentamente il ragazzo fuori da questo vortice pericoloso e a reinserirsi nel tessuto sociale, in modo più armonioso e meno conflittuale.