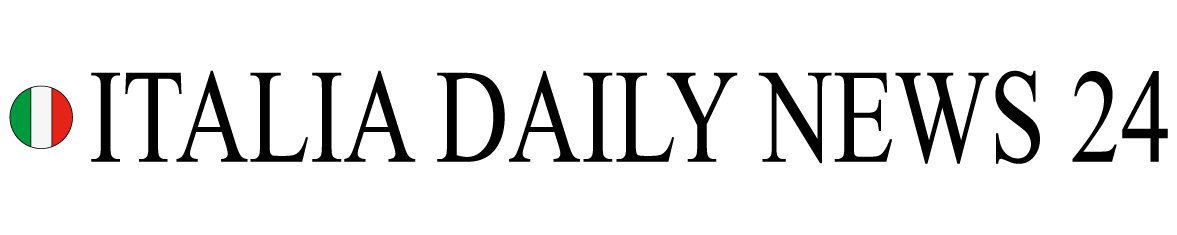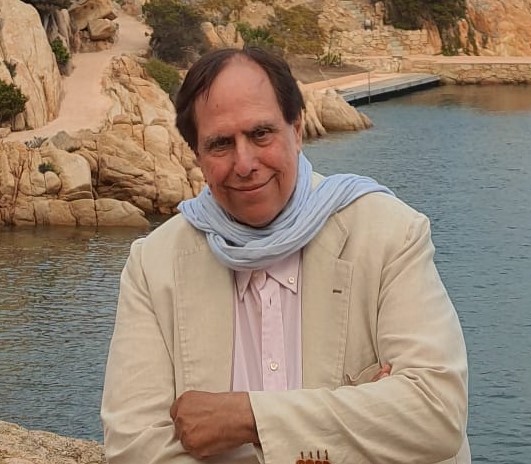In un sistema giudiziario che punta sempre più all’efficienza, il rischio è di lasciare indietro proprio coloro che hanno subito un torto: le vittime di reati. L’Avvocato Alfredo Guarino, penalista e profondo conoscitore della procedura penale, ha analizzato con noi il ruolo della vittima nel processo penale italiano, mettendo in luce le criticità dell’attuale assetto normativo rispetto alla normativa europea.
di Roberta Imbimbo
Avvocato Guarino, in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, ritiene che l’ordinamento giuridico italiano tuteli efficacemente la vittima di un reato?
Guardi, se mi chiede se la normativa italiana tuteli realmente e in modo efficace la vittima nel momento in cui si chiede l’archiviazione di una notizia di reato, le rispondo: non abbastanza. L’articolo 410 del codice di procedura penale prevede sì la possibilità per la persona offesa di opporsi alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, ma lo fa in maniera estremamente restrittiva. La vittima, infatti, può opporsi solo indicando nuove indagini da compiere o ulteriori elementi di prova. Non può invece, e questo è il punto nevralgico, contestare il merito della valutazione già compiuta dal pubblico ministero sulla base delle indagini esistenti. Questo significa che la sua voce, in quella fase delicata, ha minima libertà di parola. Ed è un limite serio. Si crea, infatti, una distanza ingiustificabile tra la giustizia come asserzione di principio e la giustizia come concreta possibilità di partecipazione attiva al processo.
Eppure, la normativa europea sembrerebbe prevedere qualcosa di più…
Esattamente. La Direttiva 2012/29/UE dell’Unione europea stabilisce all’art. 11 che ogni vittima ha diritto a chiedere il riesame della decisione di non esercitare l’azione penale. Una previsione chiara, ampia, che non pone limiti alla natura del riesame. In Italia, invece, questo possibilità non è pienamente garantita: la decisione finale spetta al GIP, che può accogliere la richiesta di archiviazione, e contro questa decisione non è ammesso un vero appello da parte della vittima, salvo che per vizi formali. In pratica, la persona offesa resta esclusa da un controllo effettivo sulla scelta del GIP di non far proseguire le indagini. Ed èun paradosso: si parla di centralità della vittima, ma poi le si nega un ruolo concreto in questa fase. La giustizia penale non può prescindere dal rispetto pieno dei diritti della vittima. Altrimenti, non è una giustizia compiuta.
Un altro aspetto critico che lei ha più volte sottolineato riguarda la difficoltà per la vittima di ottenere una definizione concreta del danno nel processo penale. Qual è la sua opinione in merito?
È una delle grandi lacune della nostra giustizia penale. Il danno subito dalla vittima, anche in caso di condanna, raramente viene definito in modo completo all’interno del processo penale. Spesso ci si limita alla concessione di una provvisionale, una somma determinata in via anticipata e parziale, ma il risarcimento effettivo viene rimandato al giudice civile. Questo significa che anche in presenza di una sentenza penale di condanna, la vittima deve attendere ancora molti anni, affrontare ulteriori processi e procedimenti, con relativi costi per ottenere ciò che le spetta. È un percorso estenuante, e spesso la vittima non ha la forza, il tempo o le risorse per affrontarlo.
Quali sono le cause di questa inefficienza?
Ci sono due motivi principali. Il primo è culturale: molti avvocati e magistrati non sono abituati a trattare il tema del risarcimento nel processo penale. Le richieste risarcitorie spesso sono generiche, e i giudici penali evitano di affrontare la questione della quantificazione del danno perché ritenuta troppo “civilistica”. Il secondo è organizzativo: la carenza di formazione specifica e il sovraccarico di lavoro spingono i giudici a rinviare la questione alla sede civile. Ma questo è un sacrificio inaccettabile per le vittime. A ciò si aggiunge la scarsa valorizzazione dell’art. 163 c.p., che consente di subordinare la sospensione condizionale della pena alla restituzione dei beni o al risarcimento del danno. Questo strumento, che potrebbe essere molto efficace per reati come truffa, furto o appropriazione indebita, e tanti altri, viene usato troppo poco. In altri Paesi, come la Spagna, il giudice subordina la sospensione alla concreta riparazione del danno entro un termine prestabilito: un modello da prendere in seria considerazione.
Avvocato Guarino, a proposito di indennizzo statale per le vittime di reati violenti, ritiene che il sistema italiano sia equo e funzionale?
Purtroppo no. I numeri parlano chiaro e sono sorprendenti: nel 2022 si sono registrati 314 omicidi, ma solo 28 sono riconducibili alla criminalità organizzata, meno del 10%. Nel 2021 erano stati 26 su un totale simile. Nello stesso 2022, tra quei 314 omicidi, ben 120 sono stati femminicidi, quindi donne assassinate spesso in ambito familiare o affettivo. Eppure, se si guarda a come sono stati distribuiti i fondi pubblici, si scopre una forte sproporzione. Il Fondo di solidarietà, dotato di ben 34 milioni di euro, ha destinato circa 29,5 milioni – quasi il 90% – a reati collegati alla criminalità organizzata. Allo stesso modo, il Fondo speciale per l’indennizzo alle vittime di crimini violenti, nel 2023, su 4,6 milioni disponibili ha destinato oltre la metà, ancora una volta, a vittime di reati mafiosi. La disparità è lampante.
Un altro grave vuoto normativo che incide sulla sicurezza e sulla dignità della vittima riguarda la cessazione automatica delle misure cautelari una volta che la sentenza penale diventa definitiva.
Esattamente! Le misure cautelari – come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, l’allontanamento dalla casa familiare o divieto di dimora – hanno una funzione fondamentale durante le indagini e il processo: proteggere la persona offesa. Tuttavia, queste misure perdono efficacia proprio nel momento in cui, paradossalmente, la vittima potrebbe averne più bisogno, cioè dopo la condanna definitiva del colpevole. È una falla che si manifesta con evidenza nei casi di maltrattamenti, atti persecutori (stalking), violenze domestiche o tentati omicidi: reati nei quali la relazione tra autore e vittima è centrale e la recidiva, purtroppo, non è rara.
Quale sarebbe, a suo avviso, la soluzione?
Occorre introdurre nel codice penale delle sanzioni accessorie o misure di sicurezza personali anche dopo la condanna, per un congruo periodo. Penso a divieti di avvicinamento prolungati, obblighi di dimora, interdizioni personalizzate. In altri Paesi, misure simili restano in vigore anche per cinque o dieci anni, in modo da garantire che la vittima non venga esposta di nuovo a un contesto pericoloso. In conclusione, per garantire una giustizia pienamente equa, la tutela delle vittime di reati deve diventare una priorità strutturale e non una concessione occasionale del sistema.