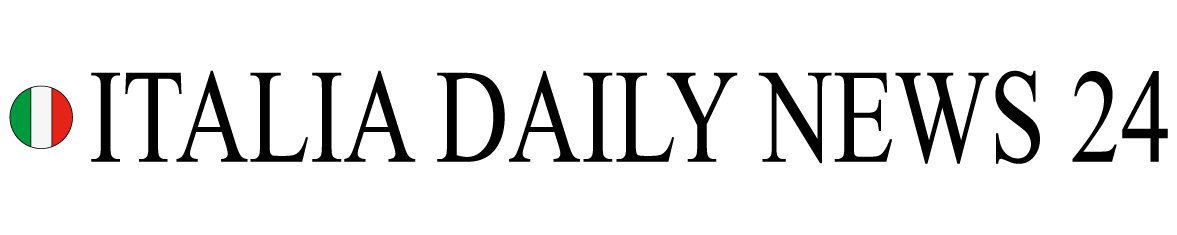DAMASCO – Li chiamano “feriti di guerra”. Ma non sono soldati tornati dal fronte, tanto meno mercenari in casa d’altri.
I feriti di guerra che si incontrano trai beneficiari del progetto Ospedali Aperti sono uomini, donne, bambini che in un istante preciso di una giornata qualunque, andando al lavoro, tornando da scuola o uscendo a fare la spesa, sono stati centrati da un mortaio o da una scheggia. A Damasco, le cose vanno ancora così: dai quartieri occupati dai “ribelli”, nascosti sotto terra, vengono lanciati mortai a qualsiasi ora, che colpiscono, feriscono, uccidono. Poi c’è la controffensiva delle truppe di Bashar al Assad. Non si capisce chi cominci per primo, da una parte o dall’altra. Le notizie arrivano filtrate da un sistema mediatico, da congegni propagandistici contrapposti, che confondono e si perdono tra annunci di attacchi finali. Intanto gli anni passano e l’elenco delle vittime cresce.
La vicenda di Jessica Abou Al Nasr, 22 anni. Si dice che chi spara preferisca farlo nei momenti della giornata in cui gli scolari tornano verso casa. Quando le strade sono più affollate e le vittime potenziali più numerose. I damasceni non hanno ancora imparato a dormire quando i cannoni sono operativi. Per chi, fortunato, non rimane ucciso dal mortaio, inizia in genere un calvario: una sequenza di interventi per aggiustare la parte di corpo offesa, o almeno provarci. Tra questi, per esempio, Jessica Abou Al Nasr, 22 anni, capelli lunghi corvini, sopracciglia curate, la mano e l’avambraccio sinistri avvolti in una spessa fasciatura. Il 25 marzo del 2017, sulla strada che la portava al negozio di parrucchiera dove era impiegata, è stata investita da un’esplosione, che le ha portato via tre dita. Si trovava nella zona vicina all’Ospedale Francese di Damasco, un quartiere popolare, densamente abitato, con traffico intenso durante il giorno. A febbraio 2018 ha subito il quarto intervento chirurgico. Il volto pallido si contrae per i dolori, mentre la mamma e il fidanzato l’accudiscono: “Jessica è stata inserita nel progetto Ospedali Aperti – spiegano i famigliari – e questa è una benedizione, perché non avremmo avuto i soldi per pagare le cure, e lei non avrebbe avuto la possibilità di riprendersi la sua vita”.
Come si fa a restare qui, a vivere, lavorare, amare? “Ci siamo abituati. I nostri figli escono di casa, ma non sappiamo se torneranno. Questa è diventata la nostra normalità”. In una stanza in penombra e in silenzio, separati da pochi metri, si trovano Fahdi Al Khouri, 50 anni, e Manal Al Hosh, 38. Marito e moglie, lui trasportatore, lei maestra. Il 22 gennaio 2018, con il figlio Eli, 3 anni, figlio unico nato dopo otto anni di matrimonio, correvano a comprare i regali per un matrimonio nel quartiere di Bap Touma. Era primo pomeriggio, per l’esattezza le 14.10, quando un mortaio li ha raggiunti. Lui è ferito al piede e al fegato, lei alla gamba. Eli è morto. Fahdi e Manal hanno ricevuto la visita del primo ministro, venuto a rendere loro omaggio. Fahdi ha lo sguardo perso nel vuoto, Manal chiama a singhiozzo suo figlio. Attorno la corona dei famigliari, che sperano nell’aiuto esterno per sostenere i costi delle cure.
Oggi a Damasco tutto costa dieci volte di più. Accanto alle vittime delle bombe, ci sono anche i malati di patologie “comuni”, che se trascurate possono condurre alla disabilità, alla non autosufficienza o alla morte. È il caso di Jamila Nassar, originaria di Homs, trasferitasi da tempo a Damasco con il marito Said Avil. Giunta all’ultimo ciclo di chemioterapia, sembra aver sconfitto un tumore tornato a manifestarsi dopo una decina d’anni. “Era guarita – racconta il Said – ma la guerra, la partenza definitiva dei nostri due figli per la Germania, la morte di un fratello in battaglia, la situazione di tensione continua, tutto questo ha risvegliato il tumore. I farmaci sono molto costosi, oggi a Damasco costa tutto dieci volte di più di prima della guerra, non avremmo potuto permettercele”.
La trama della quotidianità di una città in guerra da 7 anni. La stessa gratitudine è espressa da Najwaal al Fak, della zona rurale di Damasco: è ai piedi del letto di Camil, suo figlio diciottenne: in un grave incidente stradale si è fratturato clavicola e braccio. Per curarlo sono stati necessari interventi di chirurgia molto delicati. Camil spera di finire la scuola e intraprendere la carriera che da quando era piccolo sogna. Vorrebbe arruolarsi nell’esercito: “Queste cure decidono il mio futuro. Spero che l’incidente non comprometta tutto”. Di sicuro non ha compromesso il suo desiderio di imbracciare un’arma. Le vicende di Jessica, Fahdi, Manal, Jamila, Camil, sfiorandosi lungo i corridoi, costruiscono insieme la trama della quotidianità di una città in guerra da sette anni. L’Ospedale Francese di Damasco (oggi di nuovo colpito dai mortai), assieme all’Ospedale Italiano, sempre nella capitale e al Saint Louis di Aleppo partecipano al progetto promosso da AVSI nel 2017, con lo scopo di curare i siriani più poveri.
I poveri che già c’erano prima della guerra sono aumentati. In Siria il numero delle persone indigenti è cresciuto esponenzialmente durante la guerra, mentre l’accesso alle cure è diventato sempre più difficile, perché troppi ospedali e centri sanitari sono stati danneggiati dal conflitto e 2/3 del personale sanitario ha lasciato il Paese, oppure è rimasto sotto le bombe. Gli ospedali pubblici operativi non sono in grado di rispondere a tutte le richieste e le strutture private non riescono a offrire cure gratis senza supporto economico esterno. Ecco dunque l’idea di un grande progetto triennale “Ospedali Aperti in Siria” che, appoggiandosi a fondi privati, donazioni di imprese, fondazioni, enti privati, persone semplici, donazioni del 5×1000, ha costruito un sistema che garantisce l’accoglienza delle persone malate, la verifica delle loro condizioni tramite uffici sociali competenti e l’accesso gratuito alle cure.
Alcune nitide questioni in mezzo alla confusione. Entrare in Siria passando dalla porta di questo progetto ti apre gli occhi su poche nitide questioni. Tutto il resto resta confuso.
– La prima: il rumore delle bombe ti entra dentro. Non solo le schegge dei mortai si piantano nella carne. Anche il rumore. Per assurdo, ti abitui ma lo aspetti sempre. Si respira normalità e minaccia insieme. E questo dualismo spezza le gambe a un popolo intero. Ricostruire un Paese così spezzato sarà un’impresa titanica. Se mai qualcuno riuscirà a cominciare questa impresa.
– La seconda: la fuga dalla Siria si presenta come unica chance. Appena qualcuno ne ha la possibilità, se ne va. E perché dovrebbe tornare? E quale governo possibile sarà disposto a riprendersi quelli che costituiscono anche solo per il loro nome, una minaccia?
– La terza: la Siria documenta che quando la violenza si innesca, anche se all’inizio per “buone ragioni”, e si avvita attorno a se stessa, sa generare solo altra violenza, che perde ogni barlume di razionalità. Puoi chinarti su questo conflitto, saccheggiare analisi, ma la ragione non arriva a comprenderne il senso fino in fondo, perché non c’è più.
Si è sfibrato e consumato nella violenza incrociata e disumana che lascia sul terreno gli inermi.
Fonte http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2018/02/28/news/siria-190014966/